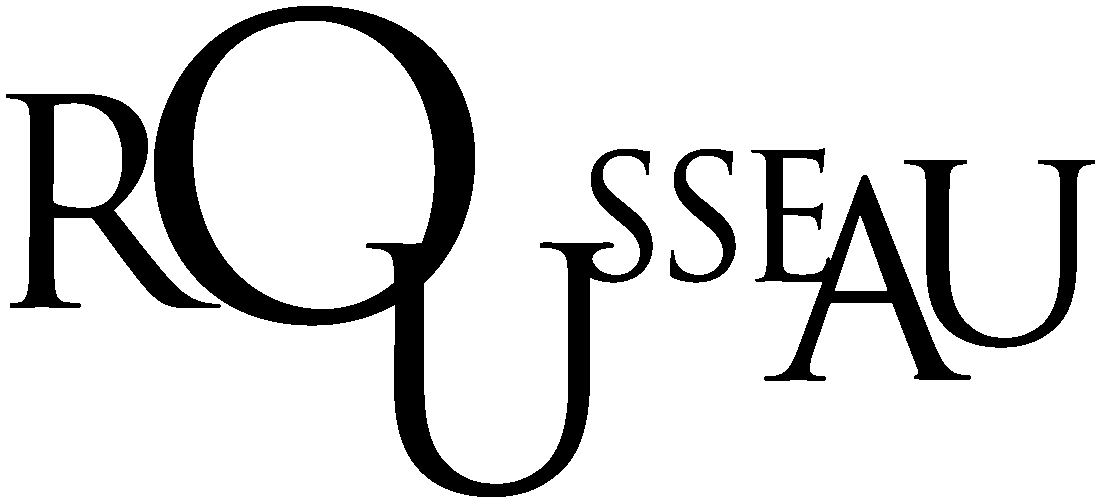di Giorgio Fontana – Ordinario di Diritto del Lavoro – Università di Reggio Calabria, pubblicato dal Fatto Quotidiano Dopo l’approvazione del decreto Dignità da parte del governo fa discutere la questione degli “effetti collaterali” della riforma dei contratti a termine (e dei contratti di somministrazione) nel settore privato. Naturalmente, se è comprensibile che qualsiasi intervento di contrasto alla liberalizzazione del mercato del lavoro possa essere sgradito alle imprese (quale imprenditore non vorrebbe tutelare la propria libertà contrattuale, in ogni campo e in ogni momento?), altra cosa è sostenere l’impatto negativo della nuova disciplina sull’occupazione. Bisognerebbe avere modelli inattaccabili, ma le stime, anche quelle dell’Inps, si basano su presunzioni incerte (come l’equazione da cui deriverebbero gli 8.000 disoccupati in più ogni anno) senza conoscere la domanda di lavoro futura. In realtà, domina ancora la convinzione che qualsiasi intervento “vincolistico” sul mercato del lavoro ha effetti raggelanti sull’occupazione, mentre invece la deregulation stimolerebbe la propensione delle imprese ad assumere. Ma non è così. Un intervento regolativo non è mai fine a se stesso. In questo caso lo scopo del decreto è ridurre la precarietà lavorativa e se ciò avvenisse si produrrebbe maggiore stabilità delle relazioni sociali, eliminando un fattore di disuguaglianza fra i lavoratori. Neppure sarebbe a priori calcolabile l’effetto sulla produttività (e di conseguenza sull’occupazione) della fiducia, della lealtà e della reciprocità, insito in un sistema più equo di rapporti fra imprese e lavoratori, ma certamente si può supporre positivo. Meno precarietà vuol dire più “capitale sociale” ed è dimostrabile il legame fra il capitale sociale (la risorsa che proviene da relazioni solidali) e lo sviluppo economico dei territori. Si sostiene che la nuova disciplina va troppo oltre, obbligando l’imprenditore, in presenza di un’esigenza produttiva non temporanea né straordinaria, ad assumere a tempo indeterminato il lavoratore. E allo stesso modo, che il tetto di 24 mesi è un vincolo troppo pesante. Ma veramente questa è una minaccia per l’economia italiana e per l’occupazione? Si potrebbe replicare che la deregulation degli anni scorsi (il decreto Poletti sul contratto a termine, ma anche la legge Biagi e il Jobs Act) non ha prodotto risultati incoraggianti e anzi, se si guardano i dati dell’occupazione, i risultati potrebbero sembrare persino fallimentari. Forse è giusto provare un’altra strada. Certamente nessun imprenditore desidera l’aumento dei salari e un maggior potere contrattuale dei lavoratori, ma gli economisti keynesiani dicono che questi sono uno stimolo per la crescita economica. In realtà è molto problematico prevedere che effetto avrà un intervento sulle regole, perché le imprese assumono quando hanno bisogno di farlo, secondo le regole esistenti in quel momento, e non assumono quando non si crea domanda di lavoro, semplicemente. Si può invece capire facilmente se le nuove regole del contratto di lavoro proteggono più il “contraente debole”, cioè il lavoratore, o chi possiede maggiore potere economico e contrattuale. Ma forse per molti questo è meno importante. Dopo lo Statuto dei Lavoratori del 1970 seguì, nel 1973, dopo appena tre anni, la crisi petrolifera e una delle più gravi recessioni della storia, ma nessuno si sognò di tornare indietro. Anche il modello oggi tanto contestato per i contratti a termine (le famose causali) è durato ininterrottamente, sia pure con diversi cambiamenti, dal 1962 (legge n. 230) fino al 2014 (decreto Poletti). Nessuno ha mai seriamente sostenuto che alimentasse la disoccupazione o deprimesse l’economia. La disciplina proposta dal governo Conte è poi, oggettivamente, fra tutte quelle che si sono succedute, una delle meno rigide, considerando che liberalizza il primo contratto a termine fino a 12 mesi, sul quale non gravano limiti di sorta. Oltre tutto è il modello che vuole l’Europa. La direttiva europea 99/70 condanna l’abuso della reiterazione dei contratti a termine e chiede agli Stati di adottare misure preventive e fra queste ci sono proprio le ragioni oggettive. Anche la direttiva sceglie, in fondo, di liberalizzare il primo contratto e di rendere più difficili i rinnovi. Il decreto Poletti, trasfuso nel Jobs Act, contrastava invece apertamente con la direttiva, rendendo incontrollato il ricorso alle assunzioni a termine, derogabile l’unico limite effettivo (quello temporale dei 36 mesi) e stabilendo per il resto sanzioni scarsamente efficaci. Sorge perciò il sospetto che le polemiche di questi giorni, alternate ai dati confusi che sono circolati, siano motivate in realtà da pregiudizi ideologici e politici, più che da reali problemi economici. Ma insistere ancora oggi sulla liberalizzazione del mercato del lavoro e sulla flessibilità come terapia per la crescita e l’occupazione fa pensare al vecchio detto “errare è umano, perseverare diabolico”.