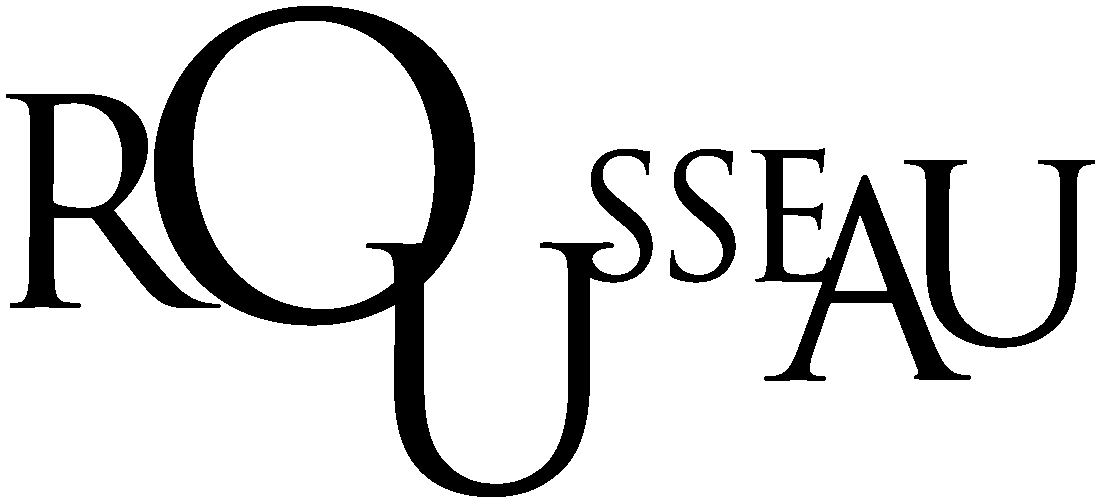L’ambientalista americano Jim Puckett ha scritto “Quando buttiamo via qualcosa dobbiamo renderci conto che questa non scompare, come vorremmo credere. Dobbiamo capire che ‘via’, in realtà, è un luogo dove l’ambiente e le persone soffrono per la nostra incuria, la nostra indifferenza o ignoranza. ‘Via’ è un posto chiamato Agbogbloshie”.
Quando buttiamo via qualcosa lo allontaniamo da noi e dal nostro sguardo, è qualcosa di cui vogliamo perdere traccia perchè lo abbiamo usato fino a esaurirne il ciclo vitale e ora ciò che resta è inutile e privo di valore, fastidioso, un rifiuto.
Quando questo processo di rimozione viene forzatamente impedito, si possono creare cortocircuiti potenti come nel caso delle fotografie che immortalano enormi discariche nelle periferie del mondo.
La fotografia per sua natura è un atto critico: scegliamo una porzione di realtà da isolare dal contesto e fissare in un’immagine. In quell’immagine essa sopravvivrà al tempo, a chi ha scattato la fotografia stessa, e percorrerà strade lontane e imprevedibili, raggiungendo milioni di occhi. La fotografia è una traccia, un’impronta. Nonostante le tecniche digitali, ancora oggi la fotografia mantiene la sua forza di dato reale, di testimonianza. Questo la rende tanto potente nel mettere sotto i nostri occhi ciò che non vorremmo vedere, per esempio dove finisce ciò che escludiamo dalla nostra vita dopo averlo sfruttato.
Agbogbloshie è un quartiere periferico di Accra, capitale del Ghana. Qui si trova una delle discariche di materiale elettronico più grandi del Paese. Gli abitanti la chiamano Sodoma e Gomorra per il paesaggio apocalittico dove uomini e animali si aggirano tra i roghi tossici dei rifiuti dati alle fiamme. Si tratta prevalentemente delle componenti in PVC di computer e monitor, da cui i frequentatori della discarica sottraggono i metalli di un qualche valore, come rame e piombo, per rivenderli.
La discarica nasce da un inganno. Il così detto e_waste, ovvero i rifiuti elettronici che non vengono riciclati, sono un problema globale ormai gravissimo: la rapida obsolescenza degli strumenti digitali ne rende necessaria la sempre più rapida sostituzione. Ogni anno vengono prodotti circa 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici (fonte United Nations Environment Programme).
Così l’Occidente, tecnologicamente più avanzato, se ne disfa inviandoli nei paesi in via di sviluppo in container su cui campeggia la scritta “donazioni”, con il presunto obiettivo di sostenere i “cugini poveri” nel colmare il digital divide. In realtà, agendo nell’ambito di falsi progetti di sviluppo, le aziende occidentali hanno potuto aggirare le normative nazionali e smaltire a basso costo e senza alcun protocollo di sicurezza rifiuti pericolosi e inquinanti.
Ad Agbogbloshie nel terreno e nell’acqua si trovano alte concentrazioni di piombo, mercurio, tallio e PVC che avvelenano chi vi abita, uomini e animali.
Il disastro ambientale non è l’unica conseguenza di questo mercato illegale. Il Ghana è uno dei primi paesi al mondo per concentrazione di cyber crimine (secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti). Nelle schede madri dei computer sopravvivono dati personali sensibili dei precedenti utilizzatori che nelle mani degli hacker possono essere utilizzati per violare i siti web e rubare informazioni.
Questa realtà è stata immortalata nel lavoro del fotografo sudafricano Pieter Hugo. La serie Permanent Erorr, il cui titolo richiama il linguaggio informatico, ritrae gli scenari di Agbogbloshie e chi li popola. Questi giovani africani dalla posa fiera e dallo sguardo puntato dritto sullo spettatore trasmettono da un lato una grande dignità umana, dall’altro un profondo imbarazzo. Il nostro imbarazzo. Queste persone che sopravvivono riciclando parte dei nostri rifiuti, ne muoiono anche. Pieter Hugo ha lavorato un anno sulla discarica, documentando ciò che vi accade e ha raccontato che tra un sopralluogo e l’altro non ha mai trovato le stesse persone. Alcune erano tornate nei poveri villaggi di provenienza, altre erano morte.
Altri fotografi e artisti hanno scelto di raccontare attraverso fotografie e video la vita nascosta delle discariche del terzo mondo per riportarla sotto i nostri occhi, nei contesti istituzionali dell’arte o in quelli dei massmedia.
Nella discarica più grande del Sud America, quella di Jardim Gramacho, a Rio de Janeiro, hanno lavorato sia l’artista brasiliano Vik Muniz, che gli ha dedicato il documentario Waste Land, diretto da Lucy Walker nel 2010, che il fotografo belga Christophe Simon, dell’agenzia AFP.
Entrambi hanno immortalato la vita dei catadores, i raccoglitori che riciclano tra le montagne di rifiuti i materiali che possono essere recuperati e venduti. Queste persone vivono nella favela vicina, sono autorizzate a lavorare nella discarica e dalla loro attività traggono sostentamento. È un lavoro pericoloso, non solo perché l’ambiente è altamente inquinato ma anche perché nella fretta di affollarsi intorno a ogni nuovo camion che arriva in discarica spesso sono vittime di incidenti mortali.
Vik Muniz non ha solo girato il documentario con l’aiuto delle persone che lavorano nella discarica. Ma dopo averle fotografate, ha trasformato i loro ritratti in enormi sculture realizzate con la spazzatura. Un ritratto e numerose foto sono stati venduti all’asta per un totale di 300 mila dollari, che l’artista ha donato ai catadores. Sono immagini di una forza straordinaria in cui convivono le iconografie della tradizione storico artistica con il materiale effimero e iper-contemporaneo del rifiuto.
Christophe Simon ha realizzato un reportage a Jardim Gramacho nel maggio 2012, poche settimana prima che la discarica fosse chiusa, dopo 34 anni di attività, e ricoperta da una montagna di terra. Il fotografo ha ripreso i catadores a lavoro chiedendosi che fine avrebbero fatto le migliaia di persone la cui vita dipendeva dall’attività della discarica. Il governo brasiliano, a ridosso della Conferenza sull’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite, Rio+20, chiudeva la discarica per inaugurare un nuovo impianto di riciclaggio, promettendo di rimborsare i catadores e di inserirli in programmi di aggiornamento professionale per permettere loro di trovare un nuovo lavoro. A distanza di anni sappiamo che queste persone sono state liquidate con un magro rimborso governativo in denaro e poi abbandonate a loro stesse.
La realtà che scopriamo attraverso l’obiettivo fotografico di Elwira Szczecian per il National Geographic è quella di Thilafushi nella Repubblica delle Maldive. In uno dei paesi più vulnerabili al mondo agli impatti del cambiamento climatico, si trova un’isola artificiale di rifiuti. Dall’inizio degli anni Novanta, l’isola cresce un metro quadrato al giorno a causa dell’enorme quantità di rifiuti prodotto dal flusso di turisti che arriva alle Maldive ogni anno (7,2 kg in media di rifiuti pro capite al giorno a fronte dei 2,8 kg di un maldiviano). Si tratta di 300 tonnellate circa al giorno. Per questo i rifiuti di ogni tipo, dagli scarti alimentari a quelli tossici, che prima venivano semplicemente abbandonati in mare, sull’isola vengono bruciati a cielo aperto con la tecnica del fuoco controllato. A Thilafushi vivono e lavorano circa 300 persone che recuperano tra i rifiuti i materiali riciclabili. Provengono prevalentemente dal Bangladesh, spesso senza permesso di lavoro e sopravvivono coltivando piccoli orti sul suolo inquinato e pescando nelle acque circostanti, quelle della così detta “laguna nera”. Molti soffrono di malattie alle vie respiratorie e la mortalità è alta, per questo ogni 3 mesi alcuni di loro vengono sostituiti.
Il paradosso di questa storia è che i turisti vanno a cercare il paradiso in terra mentre contribuiscono a distruggerlo. Solo la nube di fumo che si intravvede arrivando in aero a Male denuncia questa verità ai turisti più attenti che vanno cercando l’oblio vacanziero nei lussuosi resort maldiviani.
Ma il lavoro di un numero sempre maggiore di fotografi, videomaker e artisti rende impossibile rifugiarsi nell’oblio, rimuovendo il problema dalla nostra responsabilità. Con la forza delle immagini, esso viene messo sotto ai nostri occhi per essere ricordato, conosciuto e combattuto.