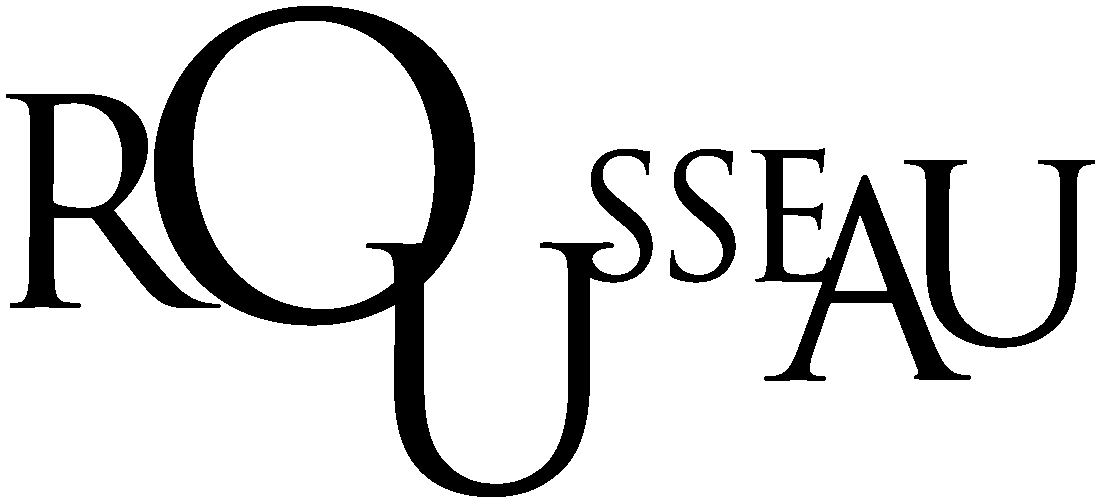da Linkiesta
Bravo, Di Maio. Lo diciamo senza un se ne un ma a spezzare l’idillio, stavolta. Lo diciamo perché il Fondo Nazionale Innovazione è davvero una misura importante per lo sviluppo dell’ecosistema italiano delle startup. Perché un miliardo sono una cifra importante come detonatore per far sì che arrivino anche – finalmente! – gli investitori istituzionali e i grandi fondi di investimento. Perché stavolta si percepisce davvero la volontà di fare sul serio per dare corpo a un sistema che è rimasto dieci passi indietro rispetto al resto d’Europa.
Non ci addentriamo nelle tecnicalità da esperti del settore. Vi basti sapere che quel miliardo, messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti, sarà investito direttamente in startup e pmi innovative, oppure in fondi che investono su di loro. E che l’idea sottostante è che questo investimento pubblico faccia da leva per attrarre ulteriori investimenti privati da parte di quei fondi stranieri che fino a oggi non hanno considerato l’Italia e le sue startup troppo piccole e fragili per tentare il salto di scala.
Parliamo di un sistema, quello italiano, in cui si celebra ancora Yoox, che era startup nei primi anni duemila. E in cui ancora si sente dire, da parte di chi non riesce a vedere al di là del proprio naso, che la startup economy è roba per fighetti con tempo da perdere, che non crea né redistribuisce valore. Sarà, ma se il dati e la loro elaborazione sono il petrolio del nuovo millennio, noi stiamo ancora andando a pedali. Nel 2018 l’investimento in startup, in Italia, è stato pari a circa 600 milioni, più del doppio rispetto al 2017, poco più delle metà di quanto si investe in Spagna, meno di un terzo rispetto a quanto si è investito in Francia, nel medesimo periodo. Ancora: nella classifica Technology Fast 500 di Deloitte che misura ogni anno la performance delle più brillanti startup del Vecchio Continente, sono le 94 realtà francesi a farla da padrone, superando agevolmente le 70 startup britanniche e le 23 realtà tedesche e le 10 italiane, meno che in Turchia e in Polonia.
Non è una questione di genius loci, né tantomeno di normativa, visto che la nostra è stata considerata una delle migliori a livello europeo. Banalmente, è una questione di soldi e dimensioni. I nostri investitori istituzionali sono piccoli, frammentati. Le nostre casse di previdenza e i nostri fondi pensioni non investono in innovazione. Gli stranieri stanno alla larga. Chiamatela fuga dei cervelli, pure questa: noi facciamo nascere le startup, noi le incubiamo, ma poi se ne vanno all’estero per crescere, per trovare quei primi milioni decisivi per andare sul mercato, che da noi non si trovano.
Chiedere di più, oggi, è fuori luogo. Semmai, il nostro è un invito a non considerare la pratica chiusa. L’Italia ha bisogno di tutta l’innovazione possibile, e concorrere a creare un nuovo ecosistema di imprese innovative in grado di innervare il nostro tessuto produttivo, di contaminarlo, di affiancarsi a esso, non è impresa che si esaurisce in un provvedimento. Serve innervare il Paese di centri per l’innovazione, di hub universitari di eccellenza che attraggano talenti, imprese, capitali, di una pubblica amministrazione sempre più digitale, di una rete internet capillare e super veloce, di decalcificare tutti i blocchi culturali e tutte le remore che il nostro Paese ha verso il nuovo e verso la tecnologia. Per dire: la Francia dell’odiato Emmanuel Macron, dopo il balzo della tigre del triennio 2014-2016 ha messo altri 10 miliardi attraverso la propria banca d’investimenti. Se nei prossimi anni vedremo un po’ meno quote 100 e un po’ più di soldi nell’innovazione, un po’ meno gilet gialli e un po’ più startupper, un po’ meno spese correnti e un po’ più di investimenti nello sviluppo di un’economia digitale, saremo i primi ad applaudire, di nuovo. Senza se e senza ma.