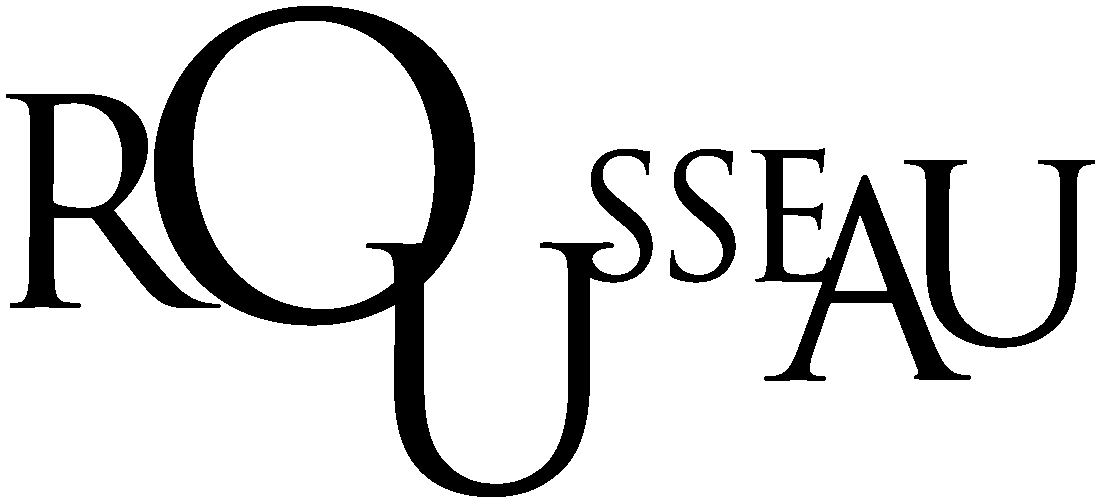L’internazionalizzazione è un valore. Lo sono gli scambi culturali, le esperienze all’estero per sperimentare stili di vita e modi di pensare diversi dal nostro, il viaggio per conoscere e riconoscere l’Altro. Siamo tutti figli del progetto Erasmus.
Ma quando abbandonare il proprio Paese senza una prospettiva di ritorno non è più una scelta ma una necessità, e il fenomeno dell’emigrazione diventa un esodo di massa, allora stiamo parlando di un’emergenza sociale.
Nel 2018 gli emigrati italiani sono stati 285 mila (dati AIRE, Anagrafe degli italiani residenti all’estero incrociati con registrazioni negli archivi statistici dei 5 principali paesi di destinazione). Una cifra quasi pari a quella record toccata nel secondo Dopoguerra: 294 mila emigrati in un anno. Per l’OCSE l’Italia è tornata ai primi posti nel mondo per emigrazione, ottava dopo Cina, Siria, Romania, Polonia, India, Messico e Vietnam, seguita da Filippine e Afghanistan. Negli ultimi 10 anni ha scalato 5 posti nella classifica dei paesi con il maggiore tasso di emigrati.
Ad andarsene sono soprattutto giovani tra i 18 e i 44 anni (il 56% del totale), dei quali il 32% è in possesso di una licenza di scuola elementare o media, il 36,3% di un diploma e il 30,6% di una laurea. Rispetto al decennio precedente il livello di istruzione di chi emigra è notevolmente più alto: ad avere una licenza elementare o media era il 51%, un diploma il 37,1% e la laurea solo l’11,9% (dati Istat).
Questa fuoriuscita continua e crescente di giovani altamente formati e con una professionalità qualificata è quella che viene definita “fuga dei cervelli”: una vera emorragia di risorse, un depauperamento del capitale sociale e umano e uno spreco di investimenti che si ripercuotono negativamente sul potenziale di sviluppo e crescita del nostro Paese. Per formare un laureato fino ai 25 anni di età sono necessari circa 170 mila euro, che salgono a 230 mila se oltre alla laurea consegue un dottorato di ricerca (dati Ocse). Confindustria ha calcolato che l’investimento in istruzione e formazione andato perso dal 2008 al 2018 su circa 260 mila giovani laureti espatriati è di 42,8 miliardi di euro, che aumentando al tasso di 14 miliardi l’anno, rappresentano un punto percentuale del Pil. Una cifra enorme.
Perché e da dove partono i nostri emigrati? E dove vanno? La ragione principale per lasciare il Paese nel tempo è rimasta sempre la stessa: cercare un lavoro. Dall’Unità di Italia fino al secondo dopoguerra si scappava dalla fame nelle campagne; oggi si scappa dalla disoccupazione, dalla precarietà o da un lavoro dequalificato e senza prospettive rispetto al proprio livello di formazione ed esperienza professionale. Dunque si parte anche dalle regioni ricche, con un alto livello di occupazione. Non stupisce che oltre la metà degli emigranti parta dalle produttive regioni del Nord Italia: Lombardia in testa (21.980), Emilia-Romagna (12.912) e Veneto (11.132), a seguire Sicilia (10.649) e Puglia (8.816). L’emigrazione dal Sud Italia è soprattutto verso il Nord del Paese, dove i giovani vanno a studiare e a cercare il primo impiego, per poi varcare eventualmente i confini nazionali in un secondo momento.
Le destinazioni principali sono per il 50% in UE (Germania e Gran Bretagna in testa, quest’ultima in ribasso dopo la Brexit) e il 40% negli USA e in America Latina.
In Europa le mete degli emigrati le seleziona il così detto wage gap: ovvero la disparità retributiva tra i diversi paesi dell’Unione. Se nei 28 stati membri infatti il costo medio di un lavoratore è di 26,80 euro l’ora, il salto tra un paese e l’altro è altissimo: si va dai 42,50 euro l’ora della Danimarca, ai 4,90 euro l’ora della Bulgaria (dati Eurostat).
In 7 dei 28 stati membri il lavoratore ha una retribuzione media superiore ai 30 mila euro annui, mentre in 10 di essi questa scende sotto i 10 mila. Queste disparità sono l’ostacolo principale allo sviluppo di un mercato del lavoro europeo omogeneo che non presenti fattori competitivi e di attrazione della forza lavoro più qualificata così schiaccianti tra la parte ricca dell’Europa e quella più povera.
L’effetto di questa disomogeneità è che pochi paesi europei sono in grado di attrarre e mantenere le energie e i talenti migliori attraverso l’offerta di lavori qualificati e ben remunerati. Di conseguenza alcuni stati capitalizzano l’investimento in formazione sui giovani laureati fatto da altri per aumentare ulteriormente il proprio sviluppo e la propria produttività.
Oltre al danno economico per il nostro Paese, che questa analisi mette in evidenza, ne esiste uno sociale non inferiore.
Se i “cervelli in fuga” grazie alle proprie capacità professionali trovano nei paesi di accoglienza condizioni lavorative migliori e quindi presumibilmente una maggiore soddisfazione e uno stile di vita più agiato, esiste parallelamente una massa invisibile di giovani con un livello di istruzione più basso e senza alcuna specializzazione che va in cerca di fortuna come facevano i loro nonni negli anni Cinquanta. Non raggiungono gli onori della cronaca per qualche impresa di successo, dunque non fanno notizia.
Questi ragazzi, i 2/3 dei giovani che emigrano, scelgono di andare all’estero perchè lì, rispetto all’Italia, è più facile perfino trovare un lavoro poco qualificato, ma soprattutto è meglio pagato. Si tratta di un esercito di camerieri, cuochi, commessi, lavoratori nei servizi a basso valore aggiunto che non trovando un welfare minimo in patria, né un’occasione per emergere, sceglie di andarsene. Molti di loro tuttavia nei paesi di accoglienza non trovano condizioni lavorative realmente migliori, tali da permettere una crescita professionale e un miglioramento dello stile di vita. Così il disagio sociale che aveva spinto la parte meno istruita dei giovani emigrati a partire si trasforma da fenomeno nazionale a europeo. A questa maggioranza invisibile di lavoratori vanno aggiunti tutti quei laureati, impossibile capire dalle statistiche quanti siano, che svolgono impieghi per i quali sono sovra qualificati.
Il quadro di riferimento che emerge sull’emigrazione italiana mostra dunque una polarizzazione: da un lato i cosiddetti “cervelli in fuga”, un terzo dei giovani emigrati ormai, il cui esodo impoverisce il Paese; dall’altro una maggioranza di disoccupati sotto qualificati che scappa dall’Italia in assenza di prospettive e sicurezze per non trovarne neppure altrove.
Questi giovani che non riescono a esprimere il proprio potenziale contribuendo allo sviluppo della società attraverso il lavoro, sono una generazione perduta, lost generation la ha definita nel 2013 Mario Draghi. Una generazione che l’Italia si perde per strada, senza poterselo permettere dal momento che è sempre più povera e sempre più vecchia. Secondo i dati di Confindustria l’occupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni in Germania è del 45,7% mentre in Italia è ferma al 16,6%.
Nel mondo globalizzato ricerca e innovazione sono la chiave di accesso al futuro e sempre più spesso a esserne protagonisti sono i giovanissimi ancora in età scolare. Sprecare il capitale umano dei nostri giovani non investendo nella loro formazione e nel successivo impiego produttivo nei diversi campi è un errore che l’Italia sta già pagando a caro prezzo.
Per questo il Movimento 5 Stelle al governo del Paese sta raddrizzando la barra, intervenendo con urgenza sui due poli del problema con misure diverse e complementari.
Da un lato disincentivare la “fuga dei cervelli”, obiettivo per il quale è necessario garantire loro uguali opportunità in patria con investimenti a favore di innovazione e ricerca, sostenendo le start up e i centri di eccellenza. È quanto si è cominciato a fare con la prima legge di bilancio approvata a dicembre scorso: con il Fondo Nazionale Innovazione e la sua dotazione di 1 miliardo l’anno per il venture capital; con maggiori finanziamenti a CNR e istituti di ricerca; con il piano straordinario di assunzioni di 1511 ricercatori universitari; con i 150 milioni di euro per progetti di ricerca industriale e sviluppo finanziati con il Fondo per la crescita sostenibile, un obbiettivo storico del M5S e molto altro ancora si potrebbe elencare.
Sull’altro versante stiamo aiutando chi da solo non ce la fa, chi fatica a emergere e trovare la sua strada, nel suo Paese come all’estero: il Reddito di Cittadinanza non è assistenzialismo ma un piano di politiche attive del lavoro, orientamento, formazione e inclusione professionale che farà la differenza per 5 milioni di persone sotto la soglia di povertà; il decreto Dignità ha già fatto la differenza, portando nei primi due mesi di quest’anno a +119% i contratti a tempo indeterminato, un’azione seria di contrasto alla precarietà dopo i disastri del Jobs Act e delle mancette renziane elargite a pioggia. Ora la legge sul salario minimo orario che sta per essere approvata è un altro mattone fondamentale di questa architettura fatta di diritti e sviluppo. Perché non ci può essere il secondo senza i primi.
Se assicuriamo uno standard retributivo minimo dignitoso e competitivo con gli altri paesi europei i nostri giovani sceglieranno di rimanere, o di rientrare, per investire energie e talento qui, a beneficio della società in cui sono nati e si sono istruiti, accanto alle loro famiglie, contribuendo al benessere generale. Colmare il divario retributivo tra l’Italia e i paesi europei più ricchi è una misura necessaria sul piano economico oltre che un atto di giustizia sociale.
Ma non basta. È necessario lavorare a un salario minimo europeo, portando la proposta del Movimento 5 Stelle a Bruxelles come previsto dal nostro Europrogramma, per evitare che le aziende delocalizzino la produzione dove il costo del lavoro è inferiore, fenomeno già scoraggiato in Italia da una norma nel decreto Dignità.
Di cose il Movimento 5 Stelle ne sta facendo molte e ancora di più ne farà. C’è una visione di insieme dietro all’azione politica che porta avanti, un’idea di Paese, un progetto ampio che va oltre l’effimera promessa elettorale. Perché la generazione perduta, abbandonata a se stessa dalla politica, troppo impegnata ad autoalimentarsi e mantenersi nei privilegi, non ha mai smesso di sognare. Quando a sognare le stesse cose si è in tanti, i sogni diventano obiettivi comuni per cui lottare. Se la generazione perduta si riconosce e prende coscienza di sé, sale al governo del Paese e comincia a cambiare le cose, per se stessa e per chi verrà dopo di lei.