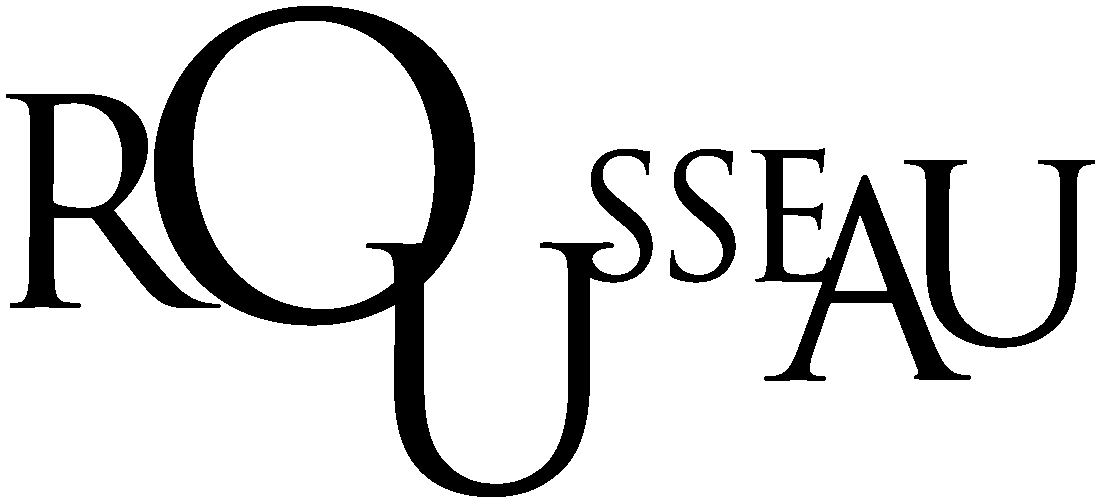L’obiezione classica quando si parla dei danni della plastica è: ma allora non devi usare il cellulare e il computer!
In effetti questo materiale, pur essendo di recente invenzione, è ormai dappertutto, negli abissi marini e perfino nelle rocce, al punto che qualcuno definisce quest’era “plasticocene”. Nessuno nega i vantaggi arrecati da questo materiale multiforme e multiuso, ma non porsi il problema del suo impatto su ambiente e salute, del fatto che il punto di forza della lunga durata è anche un grosso problema, e non cercare il più possibile alternative sostenibili sarebbe da autolesionisti.
Certo, la via maestra è in generale quella della riduzione dei rifiuti, della considerazione del loro impatto ambientale in tutte le fasi di vita. Ma abbiamo anche bisogno di concentrare l’attenzione sui nuovi materiali, di puntare con decisione sulla ricerca e sull’innovazione della cosiddetta chimica verde, per avere imballaggi e oggetti che possano garantire performance analoghe a quelle della plastica da petrolio, senza però averne gli svantaggi appena menzionati.
Una delle risposte possibili e quella più a portata di mano è la cosiddetta bioplastica, termine con il quale si definisce un materiale prodotto con elementi presi in natura. O almeno così lo intende chi ha a cuore le sorti degli ecosistemi, perché per molti la bioplastica è semplicemente un materiale che contiene la sua buona dose di inquinanti ma che però è in gradi di degradarsi quando è disperso nell’ambiente.
Tornando alle bioplastiche naturali, quelle definite “a base biologica”, esse sono spesso anche biodegradabili, in genere in impianti di compostaggio industriale, ma in alcuni casi non si degradano e invece si possono riciclare. Un esempio è il polietilene tereftalato a base biologica, ad esempio residui di canna da zucchero, che può sostituire il PET a base di olio attualmente utilizzato per produrre bottiglie di bevande.
Una delle bioplastiche più utilizzate , di origine vegetale e biodegradabile in impianti di compostaggio industriale, è l’acido polilattico (PLA), prodotto con amido vegetale fermentato come mais, canna da zucchero o polpa di barbabietola da zucchero. L’utilizzo più frequente è nella produzione di bicchieri e di contenitori per alimenti e bevande da asporto. Questo materiale, che dopo l’uso va ovviamente gettato insieme ai rifiuti organici, comporta qualche complicazione quando diventa rifiuto. Spesso infatti viene confuso con la plastica derivante da petrolio e rimosso dagli impianti di compostaggio. Allo stesso modo, a volte finisce differenziato nei contenitori della plastica (da petrolio) e dunque viene portato negli impianti di riciclaggio “contaminando” la produzione di plastica riciclata.
L’altra questione legata a questo materiale è legata al fatto che si produce con vegetali adatti all’alimentazione umana e animale. Se dunque si arrivasse davvero a sostituirlo del tutto o quasi alla plastica convenzionale, si metterebbe a rischio l’approvvigionamento di cibo e per giunta andrebbe valutato anche l’impatto ambientale delle colture dedicate.
Come spesso accade, la soluzione è in realtà un buon mix di soluzioni. In questo caso, la via maestra è quella di affiancare alla riduzione degli imballaggi e del monouso, nonché all’evoluzione del design dei prodotti, diverse tipologie di bioplastiche, preferendo quelle derivanti da scarti o da materiali più facilmente producibili o reperibili come alghe e funghi. Tutto ciò continuando ovviamente a investire in ricerca e sviluppo di soluzione sempre più sostenibili ed efficienti.
Un esempio di prodotto di scarto utilizzabile per le bioplastiche è la chitina: un polimero presente nei funghi e nell’esoscheletro di insetti e crostacei (è un sottoprodotto degli allevamenti di gamberi, granchi e aragoste) che si può convertire chimicamente in chitosano, materiale biodegradabile con proprietà antimicrobiche. Anche i pesci stessi possono essere una preziosa fonte di polimeri materiali. Discorso analogo vale per gli scarti agricoli: polimeri a base di cutina, un composto ceroso che forma il rivestimento protettivo su foglie e bucce di pomodoro, sono in fase di sperimentazione negli Usa.
L’Italia è competitiva in questo ambito, avendo la fortuna di poter vantare la presenza sul suo territorio di un’azienda leader nel settore e protagonista di un imponente operazione di riconversione dell’industria chimica tradizionale. Si tratta di Novamont, guidata da Catia Bastioli, che con il suo Mater-Bi ha intuito per prima l’importanza di puntare su pellicole degradabili e compostabili derivanti dall’amido di riso, mais, grano, patate e manioca.
L’azienda, molto attiva anche in altri Paesi, è un importante polo di ricerca e sviluppo, a conferma del fatto che anche in questo campo si può e si deve sempre fare meglio.