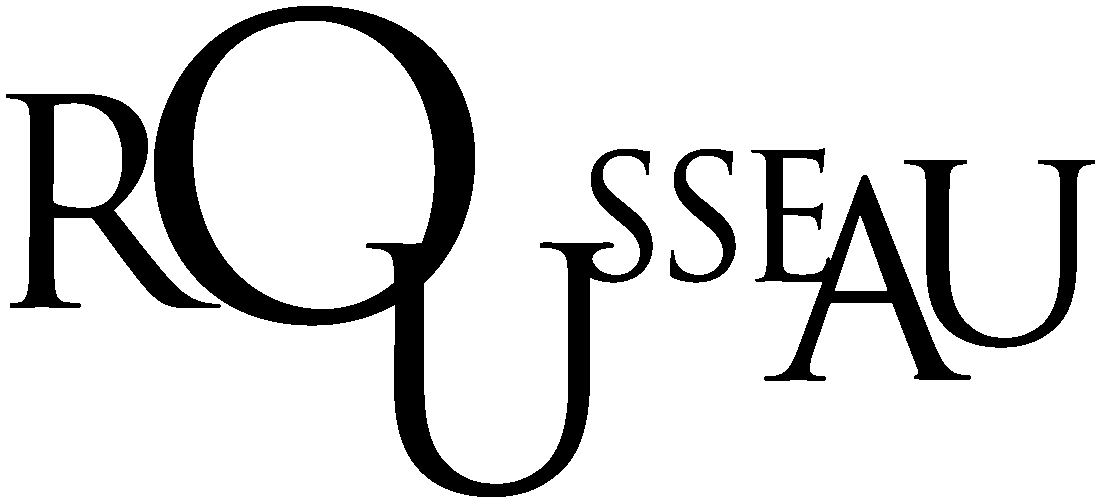Sullo scontro tra Trump e Twitter che sta facendo discutere tutto il mondo, abbiamo chiesto un punto di vista a Guido Scorza, avvocato, docente di diritto delle nuove tecnologie e giornalista.
I fatti sono probabilmente noti ai più.
Twitter nei giorni scorsi ha messo in dubbio che il Presidente degli Stati Uniti d’America, in un suo tweet, dicesse la verità a proposito del maggior rischio di brogli elettorali in caso di voto postale e ha invitato gli utenti a approfondire l’argomento attraverso un link “appiccicato” giusto sotto al tweet presidenziale.
Lo stesso contenuto pubblicato su Facebook è rimasto, invece, al suo posto e senza etichette che ne mettessero in dubbio la veridicità perché Facebook ha, da tempo, scelto di sottrarre alle proprie attività di fact checking i contenuti pubblicati dai politici.
Frattanto Trump ha risposto a Twitter con un ordine esecutivo – per la verità, secondo la quasi totalità dei giuristi americani, in odor di incostituzionalità e, quindi, sostanzialmente inefficace – con il quale stigmatizza il fact checking in suo danno e mette in dubbio che i social network si meritino l’immunità che la legge americana – come d’altra parte quella europea – accorda loro in relazione alla responsabilità per i contenuti pubblicati dagli utenti, suggerendo che visto che fanno moderazione discrezionale, meriterebbero di essere trattati come editori.
Una manciata di ore più tardi, Trump torna a twittare a proposito dei disordini di Minneapolis e chiude un tweet scrivendo: «Quando iniziano i saccheggi, si inizia anche a sparare».
Per Twitter il nuovo cinguettio presidenziale è contrario alle proprie policy in fatto di esaltazione della violenza e lo bolla come tale lasciandolo, tuttavia, visibile perché di interesse pubblico.
Nessuna “censura”, invece, su Facebook dove lo stesso contenuto è rimasto al suo posto, ancora una volta, senza nessuna etichetta.
Ce n’è abbastanza per una sfida tra super potenze.
È la tempesta perfetta scatenata da una serie di questioni straordinariamente complesse dalla cui soluzione dipende, in buona misura, il futuro del web e della nostra società.
Guai a pretendere di avere risposte giuste o capaci di mettere tutti d’accordo.
Conviene, quindi, mettere in fila i fatti e poche considerazioni più obiettive possibile lasciando, poi, che ciascuno tragga le proprie conclusioni.
Uno.
Nessuno dei due post del Presidente degli Stati Uniti viola la legge: una è una boutade priva di ogni base scientifica, probabilmente, una balla usata a fini politici e l’altra è un’uscita inopportuna che rischia di produrre l’effetto della benzina sul fuoco della violenza che già infiamma Minneapolis e gli interi Stati Uniti.
Contenuti come quelli postati da Trump affollano i social network quotidianamente, pubblicati dai profili più diversi, talvolta anche da Capi di Stato, uomini politici, intellettuali, giornalisti, personaggi dello spettacolo con analoga audience e capacità di influenzare l’opinione pubblica.
Naturalmente non è possibile per nessuno, Twitter inclusa, smentire tutte le bugie o censurare tutti i contenuti che esaltano la violenza sia in ragione delle dimensioni del fenomeno, sia in ragione della difficoltà di distinguere verità, mezze verità e balle così come di tirare una linea di confine tra chi inneggia alla violenza e chi esprime, magari con toni sopra le righe o, persino, in maniera irresponsabile, una propria opinione.
Due.
Ovviamente la moderazione dei gestori delle piattaforme di aggregazione di contenuti, anche quando “morbida”, come nel caso degli interventi di Twitter contro Trump, all’esito dei quali i contenuti sono rimasti al loro posto online ma gli utenti sono stati informati che qualcosa non andava, incidono sul dibattito pubblico in maniera significativa, ne alterano lo sviluppo, lo condizionano.
Fanno passare qualcuno per bugiardo e violento e qualcun altro no anche se, magari, lo meriterebbe.
È inevitabile.
Tre.
Twitter interviene perché considera i tweet presidenziali contrari alle proprie regole contrattuali.
Facebook non interviene perché ritiene che gli stessi identici post non siano, invece, contrari alle proprie policy.
Lo stesso contenuto, lo stesso autore, lo stesso potenziale impatto sulla società, lo stesso pubblico – o quasi – ma regole diverse, proprio come se si varcassero i confini di uno Stato per entrare in un altro.
Ma i social network non sono Stati.
Qui i fatti lasciano il posto ai dubbi: è giusto che siano i gestori delle piattaforme di aggregazione di contenuti a stabilire la dieta mediatica di miliardi di persone, il limite di sostenibilità democratica delle fake-news, la tollerabilità delle esaltazioni della violenza, nella sostanza ciò che si può dire o non dire in tutto il mondo?
E, soprattutto, è accettabile che oltre a scrivere le regole, siano le stesse piattaforme a applicarle?
Nessuna tripartizione dei poteri che pure è presupposto di democrazia. Il potere legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario nelle stesse mani, come accade nelle dittature.
Certo questa forma di governo è più efficiente della nostra e la giustizia è più celere.
Ma è democraticamente sostenibile?
Regole scritte da avvocati anziché da Governi e Parlamenti e applicate da moderatori e algoritmi anziché da Giudici e Autorità.
Tutto in nome delle dinamiche del mercato e nell’interesse degli azionisti anziché delle regole costituzionali e in nome del popolo.
E, naturalmente, le regole dei social network e delle piattaforme di aggregazione di contenuti governano oggi più rapporti di qualsiasi legge di qualsiasi Stato perché non esiste uno Stato con un numero di cittadini uguale a quello delle grandi piattaforme.
Non stiamo parlando, quindi, di un’eccezione ma della regola e di una regola che con la diffusione dell’intelligenza artificiale e dell’Internet delle cose sarà sempre più pervasiva nella nostra esistenza e presto non riguarderà solo – si fa per dire – cosa possiamo dire o non dire online ma anche come dobbiamo guidare la macchina, cosa possiamo fare dentro casa nostra, cosa possiamo mangiare e ogni altro aspetto delle nostre vite.
Quattro.
Trump mette in discussione il principio in forza del quale i social network e i gestori delle piattaforme di aggregazione contenuti non sono responsabili dei contenuti pubblicati dai loro utenti.
Non è né il primo, né il solo.
Accade negli Stati Uniti e accade in Europa dove vige più o meno la stessa regola.
Nel governo del web non c’è niente che non possa essere discusso perché la realtà è straordinariamente magmatica e in continua evoluzione ma quel principio – declinato in 26 parole nel caso della legge americana – è quello che ha consentito al web di diventare quello che conosciamo: la più grande piazza pubblica della storia dell’umanità, con tutti i suoi limiti, le sue derive e le sue patologie.
Se si stabilisse, per legge, che il gestore di una piattaforma deve rispondere quando uno qualsiasi dei suoi utenti pubblica un contenuto illecito, quel gestore difficilmente potrebbe lasciare aperti i suoi server ai contenuti di miliardi di persone in tutto il mondo senza identificarle e senza garantirsi, in qualche modo, la possibilità di chiamare, a sua volta, a rispondere l’autore del contenuto.
Esiste, una formula, non scritta e certamente imperfetta, secondo la quale all’incremento della responsabilità del gestore di una piattaforma per i contenuti pubblicati dagli utenti, corrisponde un decremento del numero di utenti ammessi a pubblicare contenuti.
E il decremento in questione è selettivo: minore per chi pubblica contenuti frivoli che non affrontano argomenti suscettibili di ledere i diritti o anche solo la suscettibilità di qualcuno e per gli utenti che si lasciano identificare e che hanno le spalle economicamente più larghe e che, quindi, potrebbero, eventualmente, ristorare il gestore della piattaforma delle conseguenze sofferte per effetto della pubblicazione del contenuto.
Se la proporzione in questione si rivelasse più o meno corretta, nello spazio di qualche mese, il web si trasformerebbe in una specie di gigantesca TV d’altri tempi attraverso la quale pochi continuerebbero a aver la possibilità di parlare e gli altri tornerebbero a non poter fare altro che ascoltare.
È il web che vogliamo?
L’alternativa è lasciare che a decidere quando è giusto che un contenuto venga rimosso o meno dal web siano giudici e autorità e, quindi, che contenuti con i quali non vorremmo imbatterci restino online più a lungo.
Frattanto si potrebbe decidere, finalmente, di investire per davvero in educazione civica digitale, educazione al consumo dell’informazione online, promozione e sviluppo dello spirito critico, alfabetizzazione degli utenti del web a verificare by default quello che si legge online senza aspettarsi che altri lo facciano al loro posto.
È un processo lento, tutto in salita, anche perché presuppone un’evoluzione quasi darwiniana di miliardi di persone, da telespettatori e lettori passivi a utenti critici e attivi del sistema mediatico globale.
Ma le scorciatoie, in democrazia, son pericolose.